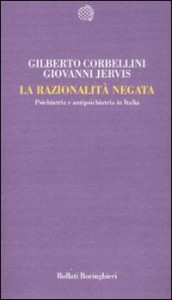La razionalità negata
GILBERTO CORBELLINI, GIOVANNI JERVIS – LA RAZIONALITÀ NEGATA
– “Il mio Manuale contrapponeva ai miti antipsichiatrici qualche nozione sensata”
– “Andai a Gorizia nel ’66 affascinato dalla sua personalità, ma avevamo opinioni diverse”
di Luciana Sica (la Repubblica, 04/09/2008)
Le aggettivazioni sono tutte al negativo: «vaga, poco chiara, generica». E poi, per trent’anni l’abbiamo chiamata legge Basaglia, ma sbagliando. Non perché l’avremmo dovuta indicare più correttamente con il numero “180” – e ai numeri siamo sempre un po’ ostici, si sa. Il punto è un altro: si doveva chiamare con un altro nome! Il vero padre di quella legge – «fatta all’italiana» – non sarebbe Basaglia, ma un medico psichiatra, un parlamentare democristiano: a Bruno Orsini si deve «la formulazione e la promulgazione» della celebre normativa che ha cancellato i manicomi.
«Lo sanno tutti!», si sorprende Giovanni Jervis, in questa intervista. «Tutti quelli che se ne sono occupati, ne sono perfettamente a conoscenza. Orsini ha raccolto le esigenze di cambiamento, certe idee che avevano conquistato un largo consenso nell’opinione pubblica, ma la sintesi è stata sua, e Basaglia non era mica d´accordo, lo ha detto subito, non gli piaceva per niente l´ispirazione generale favorevole alla medicalizzazione, considerava la psichiatria una disciplina sbagliata e oppressiva proprio per un eccesso nell’impostazione medico-biologica – quella che aveva permesso i peggiori abusi. Per dire, Basaglia non avrebbe mai voluto strutture psichiatriche come i reparti negli ospedali: immaginava piuttosto “un network di appartamenti anti-crisi”… Lui e il movimento antipsichiatrico erano violentemente contrari all’interpretazione del problema psichiatrico in termini medici – per loro era piuttosto una questione politica. Al contrario, l’impostazione di Orsini era del tipo: basta con i matti che turbano l’ordine pubblico, questa è gente che ha disturbi, insomma sono malati e come tali vanno trattati…».
“Jervis contro Basaglia”? Messa così, non si coglie il senso del nuovo libro di Giovanni Jervis che si presta poco a una lettura tanto riduttiva, a una semplificazione così sciatta, anacronistica e anche un po’ brutale, restituendo l’immagine di un duello con un’ombra (il grande psichiatra veneziano è morto nell’estate del 1980 a cinquantasei anni, per un tumore al cervello). È un pamphlet – senz’altro discutibile e decisamente destinato a far discutere – che Jervis firma con Gilberto Corbellini, un cinquantenne storico della medicina, e infatti si presenta sotto forma di dialogo: si chiama “La razionalità negata” – sottotitolo “Psichiatria e antipsichiatria in Italia” (esce giovedì 11 da Bollati Boringhieri, pagg. 174, euro 12).
Corbellini svolge un ruolo d´interlocutore dello studioso settantacinquenne, autore di saggi importanti che spesso hanno come oggetto temi sociali e politici, oggi più coinvolto nel mestiere di analista, dopo aver lasciato molto tempo fa la psichiatria “attiva” e nel 2005 l´insegnamento universitario alla “Sapienza” di Roma. È Corbellini, nelle ultime righe dell´introduzione, che incoraggia «a prendere consapevolezza dei danni, delle sofferenze e dei ritardi che una serie di irragionevoli controversie ideologiche stanno causando da quasi mezzo secolo alla vita civile italiana». Un invito genericamente rivolto a chi si occupa delle innumerevoli varianti del disturbo mentale, ma anche – e forse soprattutto – «a politici e intellettuali». Sia per la questione che si solleva – gli ideologismi che indubbiamente hanno segnato la nostra storia recente – sia per i destinatari della riflessione inevitabilmente rapida, in ballo c’è qualcosa di più di una valutazione più o meno condivisibile della legge Basaglia. L´impressione generale è quella di una presa di distanza nettissima, radicale, inequivocabile da un certo clima politico e culturale in cui si era sempre e comunque “con” o “contro” qualcuno o qualcosa.
Professor Jervis, la sua ripulsa degli anni Settanta è priva di sfumature: sembra viscerale, oltre che razionale… È vero?
«Certo, e per molte buone ragioni: ho maturato un giudizio negativo di quella stagione per quel suo gusto dell´astrattezza, la tendenza al trionfalismo e alla retorica, i settarismi, le contrapposizioni, gli schematismi, ignorando totalmente la realtà fattuale, il rigore dell’analisi, la previsione delle conseguenze di azioni o anche solo di parole… Una stagione incline alla violenza – non solo verbale, come sappiamo – intrisa anche di romanticherie vagamente spiritualiste, di confusi esistenzialismi, d’improbabili sperimentazioni, e molto più spesso di eccessi tutt’altro che innocui… Del resto, sappiamo anche come le follie collettive possano essere terribilmente normali».
La razionalità negata fa vistosamente il verso a L’istituzione negata, il famoso volume collettaneo uscito nel ’68 da Einaudi. Il sottotitolo di quel libro era “Rapporto da un ospedale psichiatrico”, e infatti si raccontava la straordinaria esperienza di Gorizia. “A cura di Franco Basaglia” era l’unica dizione che appariva in copertina. Come mai non figurava anche il suo nome?
«Perché era giusto così. Perché Basaglia era il vero artefice di quell’esperienza, era lui il capo dell’équipe. In quegli anni io ero consulente della casa editrice Einaudi e andai a Gorizia nel ’66 – avendo già in mente il progetto di quel libro – affascinato dalla personalità di Basaglia, uomo di grande intelligenza, con uno sguardo sulle cose penetrante, perspicace, spiritoso, spregiudicato in senso buono. Non si può dire che avesse un buon carattere, non era sempre facilissimo andare d’accordo con lui, ma non era mai una persona mediocre. In ogni caso io non l’ho idolatrato e molto presto è venuto fuori che avevamo opinioni diverse – mai però c’è stata una lite tra noi. Del resto, il mio maestro era già stato Ernesto De Martino, l’antropologo della devianza: non mi sono mai considerato un allievo di Basaglia, e di fatto non lo ero».
L’istituzione negata ha un successo enorme e Basaglia diventa di colpo una star. Lei che ha ammirato il modello goriziano “razionale e moderato”, nello stile delle comunità terapeutiche britanniche, detesta invece il movimento antipsichiatrico degli anni Settanta che in Italia avrà un indiscusso capo carismatico: Franco Basaglia, appunto. È questo a rendere il vostro rapporto sempre più ambivalente?
«Basaglia era un uomo ambizioso, sanamente ambizioso, e fino a quel momento con una vita professionale un po’ frustrata perché lui avrebbe voluto fare la carriera universitaria e inoltre non amava né Gorizia né i goriziani. Ma lui, uomo di forte carattere, lì aveva fatto una scommessa: voleva trasformare in un’esperienza-pilota quel vecchio ospedale retrivo in un angolo periferico d’Italia – con pochi mezzi, senza l’appoggio delle amministrazioni locali, con un paio di medici che lo spalleggiavano. E quella scommessa, lui l’ha vinta. Dopo, nulla è stato più uguale a prima, di fatto Basaglia è stato un po’ travolto dal successo, dal culto della sua personalità e dalle ubriacature ideologiche di quegli anni».
Certi suoi modi di fare non lo nobilitano: ad esempio, il rapporto piuttosto autoritario con gli infermieri, a volte con gli stessi medici… Ma che senso ha dissacrarne il mito tirando fuori questi aspetti un po’ meschini della personalità?
«Io non li considero meschini, perché Basaglia – per quanto egocentrico – non era mai un uomo volgare. Piuttosto apparteneva a una famiglia abituata a comandare. Le racconterò un aneddoto: un giorno andammo insieme a prendere la sua macchina, nel garage accanto alla stazione di Venezia. Per qualche ragione la sua auto gliel’avevano spostata, in un posto non suo e comunque molto meno prestigioso. Lui si era scocciato, e non poco. “Noi”, mi disse in quell’occasione, “certi privilegi sociali, abbiamo il difetto di prenderli un po’ per dovuti”…».
Nel ’75, da Feltrinelli, esce il “Manuale critico di psichiatria”. Piace molto quel suo libro, ma a Basaglia no. Perché?
«Il mio Manuale contrapponeva ai miti antipsichiatrici qualche nozione sensata, neppure troppo originale, spiegava che parole come delirio, allucinazione, psicosi non sono designazioni arbitrarie ma fenomeni tragicamente reali. Per Basaglia, era un’operazione culturale sbagliata: il punto è che non accettava volentieri nessun comprimario, dire che era un accentratore è dire niente. Se uno pubblicava una cosa per conto suo, era automaticamente diffidente».
Il suo “Manuale” rispecchia in pieno un certo linguaggio degli anni Settanta, è un libro “contro le istituzioni, contro la scienza borghese, contro le gerarchie e l’autorità”, in cui neppure manca quella frase-simbolo per eccellenza: “ciò che è personale è politico”. Oggi, ne “La razionalità negata”, lei dice “ammettiamolo, siamo tutti cambiati, anche noi studiosi…”. Ammetterebbe di essere cambiato un pochino più di altri?
«Il discorso politico è sempre rimasto al centro dei miei interessi, ma prima del Sessantotto credevo di più nel mondo della politica e dopo, mano a mano, com’è accaduto anche ad altri, sempre meno. Io ero un po’ filocinese, ma non sono mai andato a un’assemblea o a un corteo, non sono mai stato un militante, un organizzatore, un uomo d’apparato… Io ero un intellettuale conficcato nei libri, m’interessava la psicoanalisi seppure con molte riserve, e non disperavo di finire all’università, come poi è accaduto. Sapevo perfettamente che l’esperienza della psichiatria “attiva” sarebbe stata a termine, e lo dissi subito a Basaglia nel ’66: io vedevo il mio futuro come quello di un clinico e di uno studioso… Sì, lo ammetto: ho molto annacquato il vino politico, ma chi non l’ha fatto?».
Lei e Corbellini menate fendenti in più direzioni: sono attaccati, quasi ridicolizzati non solo gli antipsichiatri, ma anche tutti quelli che anche oggi non disdegnano la letteratura e la filosofia per la comprensione della “follia”, tenendo magari poco conto delle categorie nosografiche o delle ricerche epidemiologiche. L’intellettuale per il quale lei mostra la più totale idiosincrasia è Michel Foucault: è stato davvero un cattivo maestro?
«Di Ronald Laing, non lo direi mai: lo definirei senz’altro un antipsichiatra, ma anche un poeta, un mistico, un rinnovatore, uno spontaneista, uno che navigava su territori politico-culturali rarefatti. Foucault invece è stato proprio un cattivo maestro: uno che generalizzava molto e analizzava pochissimo, con il grave demerito di aver idealizzato la devianza sociale. È vero che non è stato il solo, ma lui l’ha fatto in modo particolarmente convincente. Non per me, comunque».
Torniamo all’oggi, con l’aiuto dei dati che fornisce Corbellini nelle ultime pagine del libro. Particolarmente sconfortanti sono quelli che confermano in modo inequivocabile l’eccessivo peso del settore privato nella cura dei malati. Nel Sud – si legge – i letti privati sono addirittura il doppio di quelli pubblici. Ma se in questo Paese regna il malaffare, se le Regioni privilegiano le cliniche convenzionate piuttosto che rafforzare le strutture territoriali pubbliche, Franco Basaglia cosa c’entra?
«Assolutamente niente. Se oggi la psichiatria continua a zoppicare, se l’assistenza ai malati è ancora quella che è, i motivi vanno fatti risalire alle derive della politica e della cultura, ai fallimenti delle Regioni, alla vulgata di certe idee antipsichiatriche. Non a Franco Basaglia, che ne è del tutto innocente… Questa è l’Italia».